A ite a iscrier contos chi nisciune at a leghere, ca sos contos veros los iscini già tottus e sos imbentaos sunu macchines chene importu? Mi lu dimandavo già iscriendelos, ma pius mi venit como de mi lu dimandare, como chi los vio attos a librittu, chi’sa pretesa chi calicunu pachet pro los leghere Carchi risposta mi l’appo dada. Primu, appo iscrittu custos contos ca sos contos mi sunu semper aggradaos, cando nos los contavana sas tzias[2], settias i’s’istrada[3], sos seros de veranu e de istìu, e sos pitzinnos ascurtavamus, tott’occios e tott’uriccias, e poi non bi resessiavamus a dormire, e cando nos los contavana sos de domo, sas nottes de iverru, sèttios i’sa jiminera, cando sa luche si nd’andavat a su primu tronu e nois nos vidiavamus sas caras rujas essinde dae s’iscuru e nos achìana pagura sas umbras nostras chi si moìana i’su muru. Mama timìat peri pius de nois, ma los contavat e los ascurtavat dae atere, che a tottus sas tzias. Cando cochìana, poi, sas eminas, pesadas in introenotte, chie vucca a furru, chie cariande, chie tendende, chie iffurrande, chie crasande, chie assentande i’sos pannos de massaria, ‘ini semper sos contos chi accumpanzavana su tribagliu: contos de mortos, de brullas, de ballentìas, de amore. Peri de amore, ma s’amore seriu, su chi pròvana belle tottus pro sos de domo issoro o pro su cumpanzu o sa cumpanza ‘e tottu vida, s’amore de cada die, no’ achet contu, est una parte de vida chi est chin nois comente unu sentìdu, comente a bìer o a intendere, e chi sentìmus petzi si nos màncata, si no’ nde lu sèccana o lu perdìmus. Sos contos de amore sunu medas vortas contos de corramenta, o de amore pacau chi nisciune però lis navat amore.
Poi m’est aggradau semper, a mannu, a intendere sos fattos de sa zente chi connoschìo, ca los sentìo peri meos, ma peri sos contos anzenos assimìzana semper, nessi unu pacu, a sos tuos, mancari, vidos pizu pizu, parjat chi nono. V’at in cada contu ‘e omine una o medas cosas chi vàlene pro tottus, chi podene sutzeder a tottus, peri in contos de zente chi achet tribaglios differentes dae su tuo, chi istat in domos chi chi’sa tua no’ ana assimizu. Comente su mèliu de sa crapa tropedìa de Umberto Saba, su dolore anzenu, si l’ascurtas, lu cumprendes, est uguale a su tuo, comente, cando ucchidiavamus su porcu, depiavamus brullare e bivere pro no’ nos arrimare a pessare e pro no’ assimizare troppu cosas de su mannale, sa cascia aperta, sa gorgovena, sa vrente, ma peri sos cascios e su thunciu, a cantos de omines vidos e intesos.
Sos contos ch’appo iscrittu sunu contos veros, peri sos ch’appo imbentau. Sa zente chi v’est i’sos contos l’appo connota o intesa lumenare. Su contu de sa crapa ‘e tziu Bachis non b’est mai sutzessu, a su ch’iscio, ma sos tzios Bachis sun’ esìstios e esistini, comente sun esìstios e esìstini sos prides, sos vichinos, sos parentes chi vortan in malu peri su sentimentu pius bellu, chi viene sutta ‘e s’affettu pius delicau e pius nettu, su disizu ‘e s’animale.
Sa vardana chi conto eo non b’est mai avvènnia – Ogai est su lumene de una viddedda, i’sartu ‘e vidda, morta dae duamiza ‘e annos – e sos bandidos e sas fiùdas ch’appo connotu eo no’ ‘ini mancu parentes de custos, ma prides maghiarjos e antzeddaos vi nd’at appiu a capiddadas e omines malos chei sos meos, capassos de violare a s’animalina e de irgannare sa zente pro nudda, v’’ini e bi sunu in tottu su mundu, e peri i’sa Sardigna nostra, a dolu mannu nostru, comente vi sunu galu, in mesu ‘e tantos izos cherfios vene dae mamas chi mai morjana, sos pitzinnos pesaos chene amore chi ucchidene innossentes pro ghirare una cadenedda a sa sorre, e mamas chi los vendene. No’ sun ammentos de libros lettos, de pessonagios chei sa zingara de Capitan Fracassa, ma sun ammentos de tzios connotos e tìmios, ma no’ sempere, i’sa pitzinnìa.
Sa esta i’su monte no’ est su contu de unu vattu solu, ma de medas. Sa zente chi chistionat e àgiti in custu contu non b’esìstiti e non b’est esìstia mai, ma fattos che a su ch’appo imbentau sunu capitaos i’Sardigna, e attos dae zente chei su contadore meu, chi sùbit su chi sa leze de su connotu pretendete.
Poi v’at conticheddos minujos, chi sun essìdas, de ispiritu o de ingenuidade, e chi no’ si podene contare, ma cada sardu nd’iscit mizas de sa vidda sua e li bisonzana pro aere un’idea de sa zente e de su mundu chi at a inghiriu. Aneddottos o barzelletteddas, comente si cherete, ma chi distinghene sos de una vidda o de unu vichinadu, ca da’ issos nàschini nonzos chi sos istranzos non bi cumprendene.
Pacos los appo postos, iscazas de unu mundu anticu chi a chie cumprendet chistionana, comente ind’una domo vetza unu cantu ‘e pulimentu tunicau in oltremare nos achet derettu pessare a canta gula ‘e colores depìat aer sa zente chi istavat in domeddas de ludu.
Sos contos mi los appo contaos pro mene, ma contandelos ‘it comente chi los sere intendende dae una vucca anzena e mi navo “Raju! Possibile chi siamus gasi, chi siamus capassos de acher cussu?” e m’ammentavo chentu omines chi si sunu resios, chi non b’ana vajulau s’offesa de chie cherìana vene, de chentu chi ana torrau su dolore chi avìana retzìu a chie no’ nd’avìat gurpa, de chentu chi non b’ana mancu cumpresu sa brulla mala ch’’ini subìnde, comente de mizas chi s’ana attu una domo i’su mundu, minore ma zusta pro issos, cajente e codoma cantu lis bastavata, e sunu imbetzaos chene timer a morrere.
Appo pessau chi sos contos sunu contos e chie los ascurtat carchi cosa imparat peri si non bi l’aggradana. E, poi, assassecus, m’appo nau “Giu’, male male ch’àndete, calicunu lu regalas, calicunu di lu coglis e su restu a sa Croce Rossa o a su ocu.” Mi dìat dispiachere ebìa si, chi’s’idea chi appo de dare provas de sa bellesa ‘e s’oranesu, l’appo istropiau, ma chie cheret bene carignat e, peri s’est irgestu e carchi vorta nde l’andat su poddiche a s’occiu, chie venit carignau, si cheret bene peri isse, cumprendete.
[1]Pacas paragulas prima: est s’unica manera chi iscio de narrer preambolo, chi i’sardu non b’esistiti.
[2]Tzias: podìo iscrier zias o tzias o in carchi atera manera. Appo iscrittu Tzias ca est su sonu pius accurtzu a s’oranesu.
[3]Istrada: est sa preda lada, su bonu ‘e sas vortas de granitu, chi achiat de panchina, e ‘it attaccada a su muru ainnantis de medas domos, i’sa garrela.
Preambolo (4)
A che pro scrivere storie che nessuno leggerà, poiché le storie vere le conoscono tutti e quelle inventate sono sciocchezze senza alcuna importanza? Me lo chiedevo scrivendole e ancora di più me lo chiedo ora, che le vedo raccolte in un libretto con la pretesa che qualcuno paghi per leggerle.
Qualche risposta me la sono data. Primo, ho scritto queste storie perché le storie mi sono sempre piaciute, quando ce le narravano le donne, sedute all’aperto, le sere di primavera e d’estate, e i bambini ascoltavamo, tutti occhi e orecchie, e poi non riuscivamo a dormire, e quando ce le narravano i familiari, nelle notti d’inverno, seduti davanti al caminetto, quando la corrente elettrica mancava dopo il primo tuono e noi vedevamo i nostri visi rossi emergere dal buio e avevamo terrore delle nostre ombre che si muovevano sulle pareti. Mamma aveva paura quanto noi delle storie, ma le raccontava e le ascoltava da altri, come tutte le donne di allora. Quando le donne facevano il pane poi, dopo essersi alzate a notte fonda, intente, davanti al forno, chi a impastare, chi a spianare, chi a infornare, chi a dividere il pane, chi a sistemarlo nei lini, erano sempre le storie che accompagnavano il lavoro: storie di uccisioni, di scherzi, di abilità, di amore. Anche di amore, ma l’amore serio, quello che sentono quasi tutti per i familiari o per il compagno o la compagna della vita, l’amore di ogni giorno, non fa storia, è una parte della vita che è con noi come un senso, come vedere o sentire, e del quale ci accorgiamo se ci manca, se ce ne privano o lo perdiamo. Le storie di amore sono molte volte storie di corna, o di amore mercenario, che però nessuno chiamava amore.
Poi mi è piaciuto sempre, da adulto, ascoltare i fatti occorsi a chi conosco, perché li sento anche miei, e, d’altronde, anche quelli degli estranei somigliano sempre, almeno un poco, ai tuoi, anche quando, visti in superficie, non si direbbe. Ci sono in ogni storia umana una o tante cose che valgono per tutti, che possono capitare a tutti, anche in storie di gente che fa lavori diversissimi dal tuo, che abita in case che non somigliano neanche alla tua. Come il belato della capra legata di Umberto Saba, il dolore altrui, se lo ascolti, lo comprendi, è uguale al tuo, come, quando uccidevamo il maiale, dovevamo scherzare e bere per non fermarci a pensare e per non trovare rassomiglianze in troppe parti del maiale, il torace aperto, la gola, la pancia, ma anche i sussulti e i lamenti, con parti di uomini visti e sentiti.
Le storie che ho scritto sono storie vere, anche quelle che ho inventato. I personaggi delle storie li ho conosciuti o sentiti descrivere. La storia della capra di tziu Bachis non è mai successa, che io sappia, ma i Bachis sono esistiti e esistono, come sono esistiti e esistono i preti, i vicini, i parenti che traducono in oscenità anche il sentimento più bello, che scorgono il desiderio animalesco anche dietro l’affetto più delicato e più pulito.
La bardana che io racconto non è mai avvenuta – Ogai è un villaggio del territorio del mio paese scomparso da duemila anni e la bardana del mio racconto non è neanche una bardana propriamente detta – e i banditi e le vedove che ho conosciuto io non erano neanche parenti di questi, ma preti maghi e concubini ce ne sono stati tantissimi e uomini cattivi come i miei personaggi, capaci di violentare come bestie e di scannare la gente per nulla, c’erano e ci sono in tutto il mondo, e anche nella nostra Sardegna, come ci sono ancora, tra tanti e tanti figli nati da mamme che non dovrebbero mai morire, i fanciulli allevati senza amore che uccidono innocenti per portare una catenina alla sorella, e mamme che li vendono.
Non sono ricordi libreschi, di personaggi come la zingara di Capitan Fracassa, ma ricordi di uomini conosciuti e, ma non sempre, temuti nella fanciullezza.
La festa nel monte non è la narrazione di un episodio, ma di molti. La gente che parla e agisce in questa storia non esiste e non è mai esistita, ma fatti come quelli che ho immaginato sono successi in Sardegna, e compiuti da persone come il mio narratore, che subisce ciò che la tradizione impone.
Poi ci sono storielle minute, che sono più battute, di spirito o di ingenuità, e che non si possono narrare, ma ogni sardo ne conosce migliaia del proprio paese e le usa per formarsi il giusto concetto della gente e del mondo che lo circondano. Aneddoti o barzellettine, come si preferisce, ma che distinguono gli abitanti di un paese o di un rione, perché da essi nascono modi di dire che il forestiero non comprende.
Qualcuno l’ho incluso, frammenti di un mondo antico che parlano a chi vuole capire, come un pezzo d’intonaco dipinto in blu oltremare in una casa antica diruta ci fa subito intendere il desiderio di colore che avevano gli abitanti di casette di fango.
Le storie le ho raccontate per me stesso, ma raccontarle è stato un po’ come sentirle da altre labbra, per cui mi dicevo: ”Caspita! Possibile che siamo così, che siamo capaci di fare questo?” e ricordavo cento uomini che si sono arresi, che non hanno retto all’insulto di chi amavano, di cento che hanno restituito il torto subito a chi non ne era colpevole, di cento che non sono mai stati coscienti della cattiveria che subivano, come di migliaia che si sono fatti la casa nel mondo, piccola ma adatta a loro, calda e comoda quanto a loro bastava, e sono invecchiati senza avere paura di morire.
Ho pensato che le storie sono storie e chi le ascolta apprende qualcosa anche quando non le gradisce. E poi, alla fin dei conti, mi sono detto “Giulio, per male che vada, qualcuno lo regali, qualcuno lo tieni per te e il rimanente lo dai alla Croce Rossa o lo getti nel fuoco.”
Mi
dispiacerebbe solo se, intendendo mostrare la bellezza del linguaggio oranese,
ne avessi fatto strazio, ma chi ama accarezza e, quand’anche capita che chi
accarezza è maldestro e fa male, chi è accarezzato, se ama, capisce.
[4]Preambolo: non esiste una letteratura sarda, per cui il termine preambolo non è mai servito. In questo caso ho operato una traduzione dall’italiano al sardo, come mi succederà altre volte, in contrasto con le mie intenzioni. Il fatto è che un sardo narrante non fa preamboli o, in ogni caso, non sa di farlo.
Per leggere le storie clicca

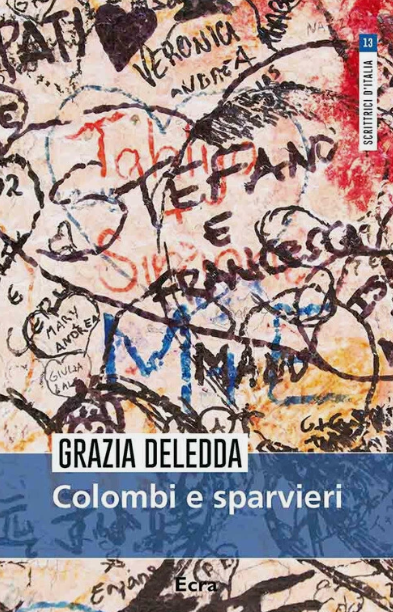
Info sull'autore